
Valore assicurato per il nuovo Terzo settore
4 Aprile 2019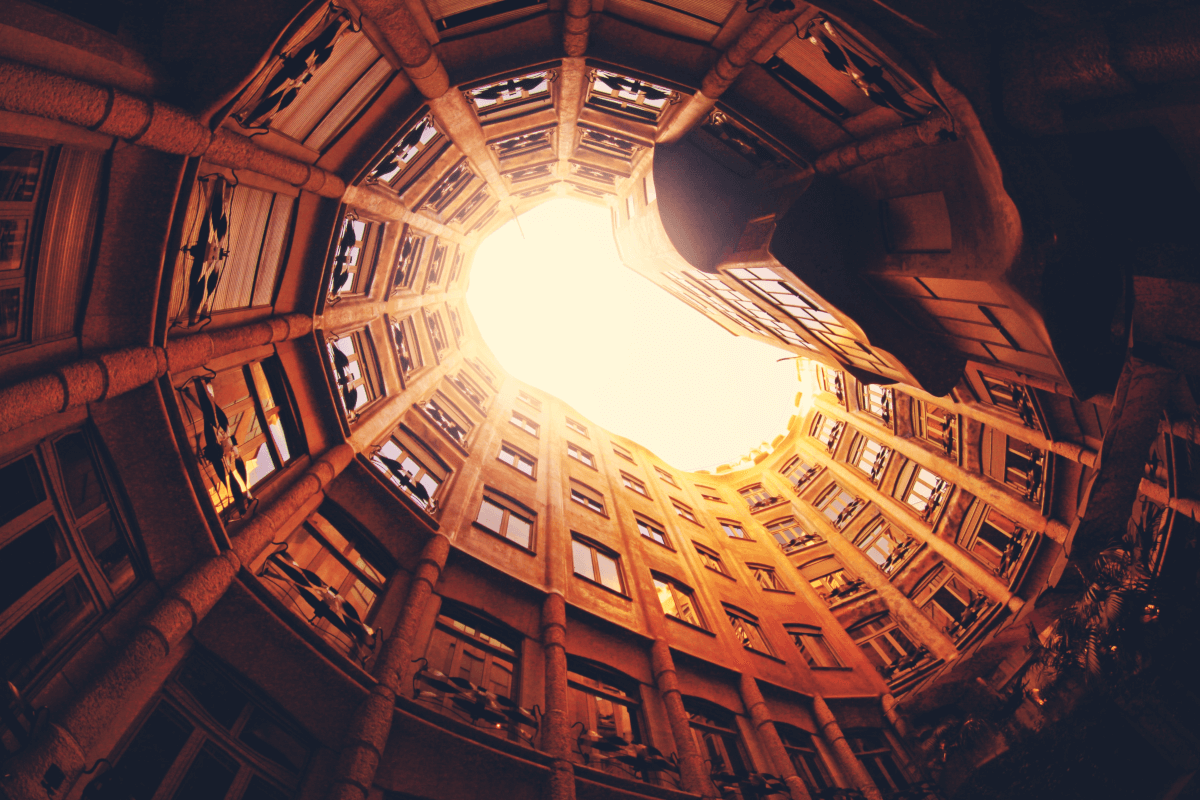
Imprese sociali, patrimonio d’Europa
4 Aprile 2019 Articolo di Stefano Zamagni, Presidente della Commissione Scientifica di AICCON
Articolo di Stefano Zamagni, Presidente della Commissione Scientifica di AICCON
Perché nonostante la sua storia esemplare e le innumerevoli opere dì bene realizzate il Terzo Settore nel nostro Paese continua ad essere narrato con sufficienza e tutt’al più tollerato?
Per rispondere conviene prestare attenzione alle due posizioni principali nel modo di concepire il senso e la missione degli Ets: appunto gli Enti del Terzo settore. V’é la posizione di coloro che vedono tali soggetti come l’eccezione alla regola, rappresentata dalla centralità delle organizzazioni for profit e degli enti pubblici. Un’eccezione bensì importante e lodevole, da sostenere e da favorire anche sul piano fiscale, ma pur sempre una realtà di cui si potrebbe anche fare a meno.
V’é poi la posizione di chi considera il Terzo settore come elemento di disturbo o di delegittimazione nei confronti dell’intervento pubblico. Per costoro un’ulteriore espansione del Terzo settore – in Italia si tratta di oltre 336.000 enti che occupano oltre un milione di lavoratori (dati Istat 2016) – finirebbe per ritardare la piena realizzazione della cittadinanza democratica, la quale sola potrebbe assicurare il rispetto dell’individuo qua cittadino e non già qua prossimo.
La virtù decresce con il non-uso
Nonostante le differenze, entrambe le posizioni celano una comune aporia. Chi privilegia la posizione «neo-liberista» vede nel Terzo settore uno strumento per sostenere il modello del «conservatorismo compassionevole». Chi invece accoglie la concezione neostatalista non accetta che nella società possano operare soggetti privati il cui fine sia l’utilità sociale o l’interesse generale. Ritenendo di poter imporre per via di comando l’attuazione dei diritti di cittadinanza, tale concezione spiazza la cultura del dono come gratuità, negando, a livello di discorso pubblico, ogni valenza al principio di fraternità.
Se a tutto e a tutti pensa lo Stato – posto che ciò sia possibile – è chiaro che quella virtù civile che è lo spirito del dono (da non confondersi con la donazione) non potrà che andare incontro a una lenta atrofia. La virtù infatti, a differenza di quel che accade con una risorsa scarsa, si decumula con il non uso. È veramente singolare che non ci si renda conto che entrambe le posizioni finiscono col relegare valori come solidarietà e reciprocità alla sfera privata, espellendoli da quella pubblica. La posizione neo-liberista perché’ ritiene che all’economia bastino i contratti, gli incentivi e ben definite regole del gioco, la posizione neo-statalista, invece, perché ritiene che per la solidarietà basti lo Stato, il quale può appellarsi alla giustizia, ma non certo alla fraternità.
Ebbene, il cambiamento oggi necessario è di andare oltre questo schema, datato e incapace di far presa sulla realtà. È grottesco continuare a considerare gli enti del Terzo settore come soggetti per la produzione di quei beni e servizi che né lo Stato né il mercato hanno interesse oppure la capacità di produrre. Piuttosto, vanno visti come una specifica forma di governance basata sul mutuo aiuto e sulla democrazia, il che implica che il Terzo settore non può esimersi dal porre in cima ai propri obiettivi la rigenerazione della comunità.
Andare oltre le «passioni tristi»
E questo un modo di impegno politico complementare – e non alternativo, si badi – a quello tradizionale basato sui partiti, un modo che consente alle persone, la cui voce mai verrebbe altrimenti udita, di contribuire a dilatare il processo di inclusione sia sociale sia economica. Quella dell’organizzazione della comunità è una strategia né meramente rivendicativa né tesa a creare movimenti di protesta. Piuttosto mira a porre in pratica il principio di sussidiarietà circolare-la cui prima formulazione risale a Bonaventura da Bagnoregio alla fine del XIII secolo – articolando in modo paritetico le relazioni tra Stato, Mercato, Comunità. È in ciò il cuore del modello tripolare di ordine sociale che accanto al privato e al pubblico pone- con pari dignità – il civile.
Se questo è il fine che si vuole perseguire si capisce perché la sussidiarietà orizzontale non basti più: privilegiando il rapporto diretto fra ente pubblico e Ets questa versione della sussidiarietà finisce con il rafforzare il modello del neo-statalismo benevolente. La vera sussidiarietà, invece, è quella che non esclude la business community nel momento in cui si tratta di decidere le priorità degli interventi; di reperire le risorse necessarie; di individuare i modi efficaci di gestione delle stesse. Ebbene va riconosciuto che l’Emilia-Romagna è la regione italiana che già da qualche tempo ha imboccato – con discreto successo -a sentiero della sussidiarietà circolare.
Certo, la strada da fare è ancora lunga e irta di ostacoli, ma non v’è dubbio che essa non abbia alternative, sempre che si voglia porre mano alla trasformazione dell’attuale modello di sviluppo ormai non più sostenibile. È possibile questo? Sì, a patto che ci si liberi di quelle «passioni tristi» di cui ha scritto Baruch Spinoza e che si ritorni – come già avvenne al tempo dell’Umanesimo civile – a coltivare la capacità di aspirare, che è quella capacità delle persone di partecipare alla costruzione delle rappresentazioni simboliche che danno forma al futuro.
Fonte: Articolo pubblicato su Corriere Buona Notizie (19 marzo 2019)




