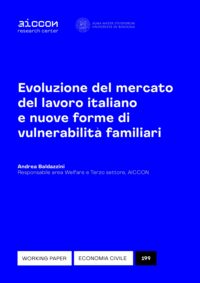199 – Evoluzione del mercato del lavoro italiano e nuove forme di vulnerabilità familiari
Andrea Baldazzini, Responsabile area Welfare e Terzo settore, AICCON
Da sempre uno degli elementi che maggiormente incide sulle possibilità e modalità attraverso cui le famiglie si strutturano ed evolvono, è rappresentato dal sistema del lavoro e dalle sue trasformazioni. La rilevanza di tale tematica occupa inoltre un posto di primo piano sia nell’ambito della ricerca accademica (Saraceno 2015;), sia in quello delle politiche e dei servizi alla persona (Ciarini 2020). Se a ciò aggiungiamo quanto accaduto nell’ultimo triennio in termini di aumento del costo della vita e stallo dell’adeguamento salariale, diventa facile intuire quanto le famiglie si trovino in un momento di particolare difficoltà e quanto questo si traduca in un ulteriore carico per i sistemi di welfare e per tutte le organizzazioni di Terzo settore che a vario titolo sono impegnate sui fronti del contrasto alle disuguaglianze, povertà e inclusione.
Non solo, nello stesso periodo si sta assistendo a quello che si potrebbe definire un vero e proprio cambio di paradigma della cultura del lavoro. Quest’ultimo dunque non sta mutando solo dal punto di vista delle opportunità lavorative e delle dinamiche produttive, ma anche in relazione alle nuove aspettative e aspirazioni delle persone che vivono il periodo attuale come momento per rimettere in discussione gli assunti di senso e significato sui quali hanno poggiato fino ad ora le personali scelte in materia di percorso professionale.
All’interno del presente lavoro però si è deciso di concentrare l’attenzione solo su alcune trasformazioni della struttura del sistema italiano del lavoro, e soprattutto su come ciò si sia tradotto in un fattore di innesco per la formazione di contesti familiari altamente fragili e soggetti a un numero crescente di vulnerabilità.
Per riuscire in questo, la prima parte del contributo avrà un carattere maggiormente teorico-ricostruttivo dove si andranno ad evidenziare un insieme di eventi particolarmente significativi dai quali si sono originati cambiamenti sistemici nell’assetto del mercato del lavoro italiano. La seconda parte invece intende ragionare più da vicino su quelle che sono le condizioni materiali delle famiglie, e per farlo si utilizzeranno come riferimento le evidenze emerse da una precedente ricerca condotta tra il 2020 e il 2021 sulla città di Bologna.
Si è ben consapevoli che la generalizzazione di considerazioni fatta a partire da uno sguardo su un contesto molto specifico e come tale del tutto sui generis, comporti grandi rischi, ma al contempo si è convinti che sia possibile e utile tentare di mettere in evidenza alcuni fili rossi che legano l’evoluzione di un determinato sistema di funzione quale è quello del lavoro con l’evoluzione degli assetti familiari di una determinata fascia di popolazione e i cambiamenti in merito alle loro istanze del bisogno. Importante è precisare fin da subito che la tipologia di famiglie qui attenzionate si possono inquadrare come appartenenti a quella che in passato si usava definire “classe media”, pertanto lo sguardo adottato non è stato volutamente orientato verso quei nuclei caratterizzati da gravi forme di marginalità o già in carico ai servizi sociali locali.
Vi è l’idea che ci siano fasce di popolazione le cui difficoltà risultano ancora troppo poco conosciute, e pertanto si rende necessario indagarle tenendo a mente quelli che sono i grandi cambiamenti dei sistemi che in passato garantiva inclusione e autonomia. Comprendere in che modo l’attività lavorativa, e non solo l’assenza di lavoro, impatti sull’organizzazione famigliare costituisce perciò un aspetto decisivo per orientare sia gli interventi a sostegno di coloro che si trovano in difficoltà, sia per prevenire il cristallizzarsi di nuove ed ulteriori situazioni di disagio all’interno del nucleo famigliare. Solitamente infatti l’attenzione è rivolta all’analisi di quelle situazioni familiari in cui il peggioramento della qualità della vita o il versare in condizioni di difficoltà deriva da un’assenza, una perdita o una quantità insufficiente del lavoro.
Riguardo invece alle famiglie in oggetto, sarà interessante osservare meglio in che modo per loro il lavoro diventa una fonte di vulnerabilità non solo in caso di sua assenza, ma anche quando è presente ed associato a carriere e inquadramenti stabili, afferenti alle più diffuse tipologie lavorative. Aspetto solo in apparenza paradossale che trova una propria ragione in virtù degli assetti familiari, delle loro abitudini, nonché delle capacità di operare un controllo e immaginare il futuro della famiglia. Almeno in un primo momento però si desidera non mettere al centro né i concetti di ceto o classe sociale, limitandosi a parlare di una fascia di popolazione dove rientrano famiglie dalle condizioni economiche molto differenti, sia prima che dopo lo scoppio della pandemia, ma comunque accomunate da comuni elementi di fragilità. Si intende procedere con cautela anche a riguardo di affermazioni relative all’emergere o meno di nuove forme di povertà. Considerato il gruppo molto limitato di famiglie risulterebbe una forzatura proporre considerazioni troppo ampie, eppure si crede fermamente che esse possano fornire riferimenti indispensabili per comprendere cosa sia avvenuto nel recente periodo, e quali siano le dinamiche che negli ultimi anni hanno spinto migliaia di persone a chiedere per la prima volta aiuto a realtà quali le Caritas o i servizi sociali territoriali.
Prima però di affrontare il tema relativo ai cambiamenti del sistema del lavoro, è doverosa un’ultima precisazione utile a chiarire le premesse da cui prende le mosse il presente lavoro. Soprattutto all’interno del dibattito accademico, le questioni afferenti ai processi di vulnerabilizzazione delle famiglie in riferimento alle tipologie di lavoro, sono spesso ricondotte ai concetti di working poor (Standing 2014) e di in-work poverty (Saraceno 2015), ovvero a situazioni in cui la persona è inserita in un percorso lavorativo, il quale però non riesce a offrirgli le condizioni minime di sicurezza sul fronte reddituale e della stabilità. Le famiglie incontrate nell’ambito della ricerca sopra menzionata, per caratteristiche che saranno descritte in seguito, non possono essere ricondotte a nessuna delle due categorie analitiche appena citate.
Pertanto, lo sforzo sarà in primis quello di descrivere assetti lavorativi e familiari ancora differenti che richiederanno probabilmente la formulazione di inquadramenti ad hoc. Come già scriveva Robert Castel (2007): «il modello proposto non è statico. Si tratta non tanto di collocare degli individui in queste ‘zone’, quanto di chiarire i processi che li fanno transitare dall’una all’altra, per esempio che li fanno passare dall’integrazione alla vulnerabilità, o basculare tra la vulnerabilità e l’inesistenza sociale: come sono alimentati questi spazi sociali, come si mantengono e soprattutto come si disfano gli status?».
Ecco allora che un approfondimento su quella che qui sarà definita ‘dimensione materiale’, comprendente gli ambiti del lavoro, del reddito, delle spese e dei risparmi, offre una porta di accesso per entrare nella vita non solo delle famiglie incontrate, ma di tutte coloro che in maniera simile si sono trovate a dover affrontare criticità improvvise prendendo consapevolezza, forse in modo inedito, delle proprie fragilità.