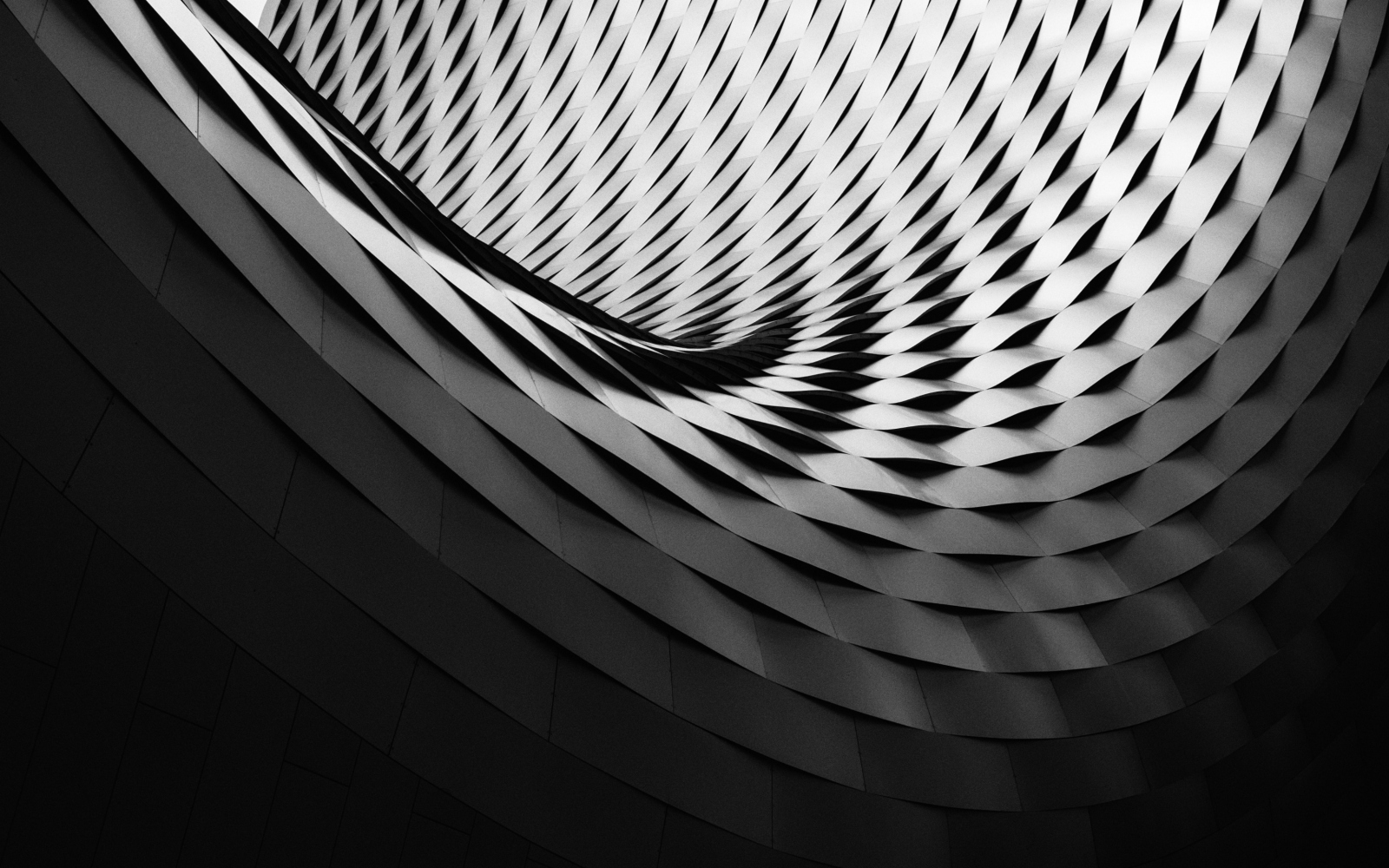
Il peer to peer innova le banche e dà più fiducia
20 Febbraio 2017
La condivisione è economia di mercato
4 Aprile 2017Articolo di Pier Luigi Sacco, membro della Commissione Scientifica di AICCON
In questi mesi, forse anche come conseguenza della visibilità e dei risultati prodotti dal programma delle Capitali Italiane della Cultura (dalla bella esperienza di Mantova 2016 al promettente avvio di Pistoia 2017 all’annuncio, che ha avuto una vasta eco, della scelta di Palermo per il 2018), si assiste ad un rinnovato interesse per i temi dello sviluppo locale a base culturale. Una recente tavola rotonda tenutasi a Palazzo Fava a Bologna, nella cornice di un’Arte Fiera rinnovata e nel contesto di Genus Bononiae, è servita per fare il punto sullo stato dell’arte. Se si legge questo momento di effervescenza in concomitanza con il recente lancio del Piano Strategico Nazionale del Turismo che finalmente dà al nostro Paese un impulso a ragionare di turismo e promozione territoriale in modo innovativo, vi è un chiaro segnale di opportunità da cogliere e possibilmente rafforzare. In che modo, dunque, è possibile tornare a ragionare di sviluppo locale a base culturale in un Paese che sembra aver smarrito la capacità di crescere e di raggiungere livelli di produttività paragonabili a quelli di altri paesi avanzati?
Il caso di Bologna può essere considerato per molti versi esemplificativo in questo senso. Bologna è stata per lungo tempo una delle capitali (se non la capitale) della cultura alternativa italiana, aperta al dialogo con molte delle più avanzate realtà europee e spesso mondiali in una varietà di campi, dalla letteratura alla musica alle arti visive al cinema, per limitarci a qualche esempio tra i più ovvi. Bologna è inoltre una delle più grandi città universitarie italiane, con uno straordinario potenziale di energie e competenze giovani che oggi, a differenza di quanto accadeva nei periodi di massima vivacità culturale, faticano a trovare luoghi e progetti di riferimento e spazio per nuove proposte progettuali. Bologna è infine una città che per tradizione ha sempre dato un ruolo importante alla cultura nei processi di trasformazione e riconversione urbana e che pure, in un momento in cui tante aree della città sono appunto in divenire, non sembra riuscire a dare all’azione culturale un’incisività sufficiente a funzionare da apripista di un nuovo ciclo di innovazione sociale inclusiva e generativa. Anche dove sembrano esserci le condizioni più favorevoli, dunque, sembra mancare qualcosa. Ma cosa in particolare? E cosa è possibile fare, in concreto?
Il primo, indispensabile passo è quello di abbandonare una volta per tutte un’idea dello sviluppo culturale basato sui grandi eventi, di una cultura che resta sostanzialmente estranea al tessuto sociale e civile della comunità locale e che trova la sua giustificazione soltanto nel ritorno economico immediato che riesce a generare (comprensivo delle forme tradizionali di indotto).
Al contrario, bisogna pensare alla cultura come ad un ecosistema nel quale le varie dimensioni, dalla partecipazione dei cittadini all’educazione, dalle contaminazioni con i più vari settori sociali e produttivi alla produzione culturale e creativa vera e propria, sono legati da interdipendenze molto più complesse e interessanti di quanto si immagini normalmente.
Questo è particolarmente importante in un Paese come l’Italia dove una delle principali criticità del modello competitivo sta nella scarsissima capacità di integrare le competenze avanzate nelle catene del valore, finendo così per appiattirsi su un modello convenzionale di manifattura (con le dovute, straordinarie eccezioni naturalmente) i cui riferimenti competitivi più prossimi sembrano essere le economie emergenti piuttosto che le altre economie avanzate.
La cultura, da questo punto di vista, può essere una piattaforma innovativa di straordinaria importanza, e lo testimoniano tante storie di successo di aziende grandi e piccole, in territori centrali ma anche marginali della geografia produttiva italiana, che hanno saputo davvero fare tesoro di questa lezione: si pensi, per limitarci a qualche esempio, ad Elica (Fabriano); Bonotto (Molvena); Lanificio Leo (Soveria Mannelli); M**bun (Rivoli): il Nordest e il Profondo Sud, la Terza Italia e il vecchio Nordovest Industriale. Un approccio intelligente alla cultura permette di ridefinire il senso stesso della percezione del valore che sta attorno al prodotto, ed è alla portata, come mostrano gli esempi, delle dimensioni di azienda più diverse.
Allo stesso tempo, una concezione eco-sistemica della cultura permette di affrontare con una logica nuova anche molti dei temi cruciali delle politiche del nostro tempo: welfare e invecchiamento attivo, sostenibilità socio-ambientale, lifelong learning, coesione sociale e dialogo interculturale.
In questa prospettiva, i musei stessi trovano la loro vocazione più interessante non tanto nell’essere “macchine di intrattenimento” (ne abbiamo già fin troppe, anche senza uscire di casa) ma piuttosto luoghi della capacitazione individuale e collettiva, “piazze del sapere”, per riprendere la felice espressione coniata da Antonella Agnoli con riferimento alle biblioteche, «altri luoghi-chiave di una concezione eco-sistemica della cultura». E sono proprio città come Bologna che si candiderebbero ad essere laboratori ideali di questa profonda trasformazione del senso e delle forme delle politiche culturali.
Non è un caso che in molte delle città universitarie che rappresentano la frontiera dell’innovazione globale, come ad esempio Boston, si assiste oggi ad un dibattito vivacissimo su come far diventare la cultura il prossimo, decisivo canale di accelerazione innovativa, e la palese superiorità di una visione eco-sistemica piuttosto che settoriale della cultura nell’orientare il cambiamento si sta riflettendo in una profonda ridefinizione delle stesse geografie locali della produzione e della partecipazione culturale. Se vogliamo esplorare seriamente delle alternative per ridare all’Italia una visione di futuro su cui costruire conforme alla nostra storia e alle nostre caratteristiche, piuttosto che delle soluzioni estemporanee che si accontentano di piccoli miglioramenti incrementali dello status quo (con i risultati che abbiamo tristemente raccolto per tanti, troppi degli ultimi anni), questa è una delle strade da percorrere. Con decisione, coraggio, e soprattutto investendo risorse ed energie, e non solo buoni propositi.
Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore (19 febbraio 2017)
Vuoi saperne di più?
Ti aspettiamo al corso Cultura e Fundraising il 20 e 21 settembre 2018 a Forlì!




