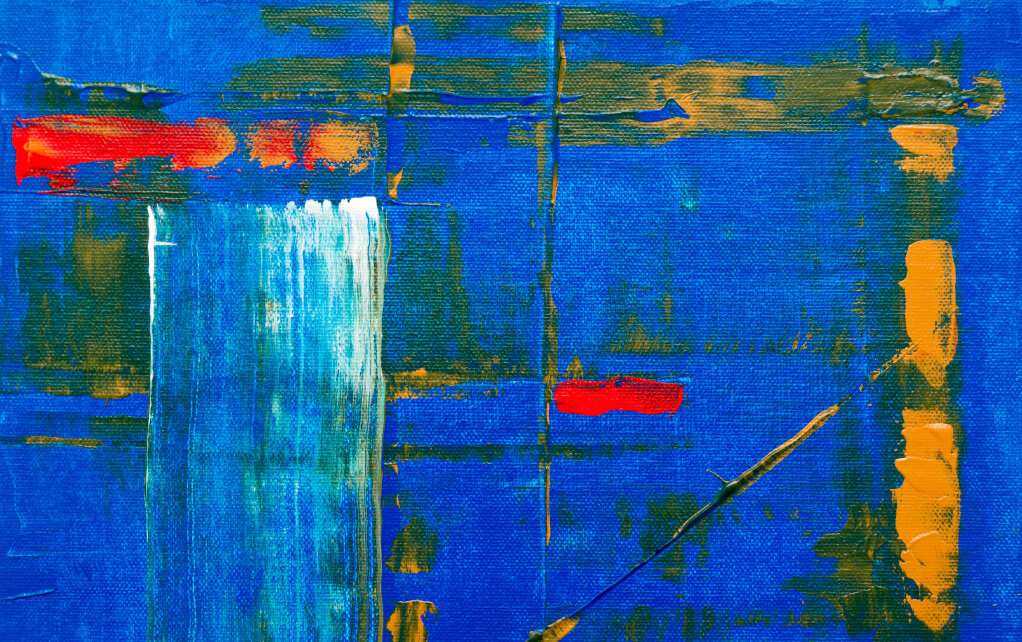
Imprese sociali: riscoprire la desiderabilità del rischio per il bene comune
7 Maggio 2021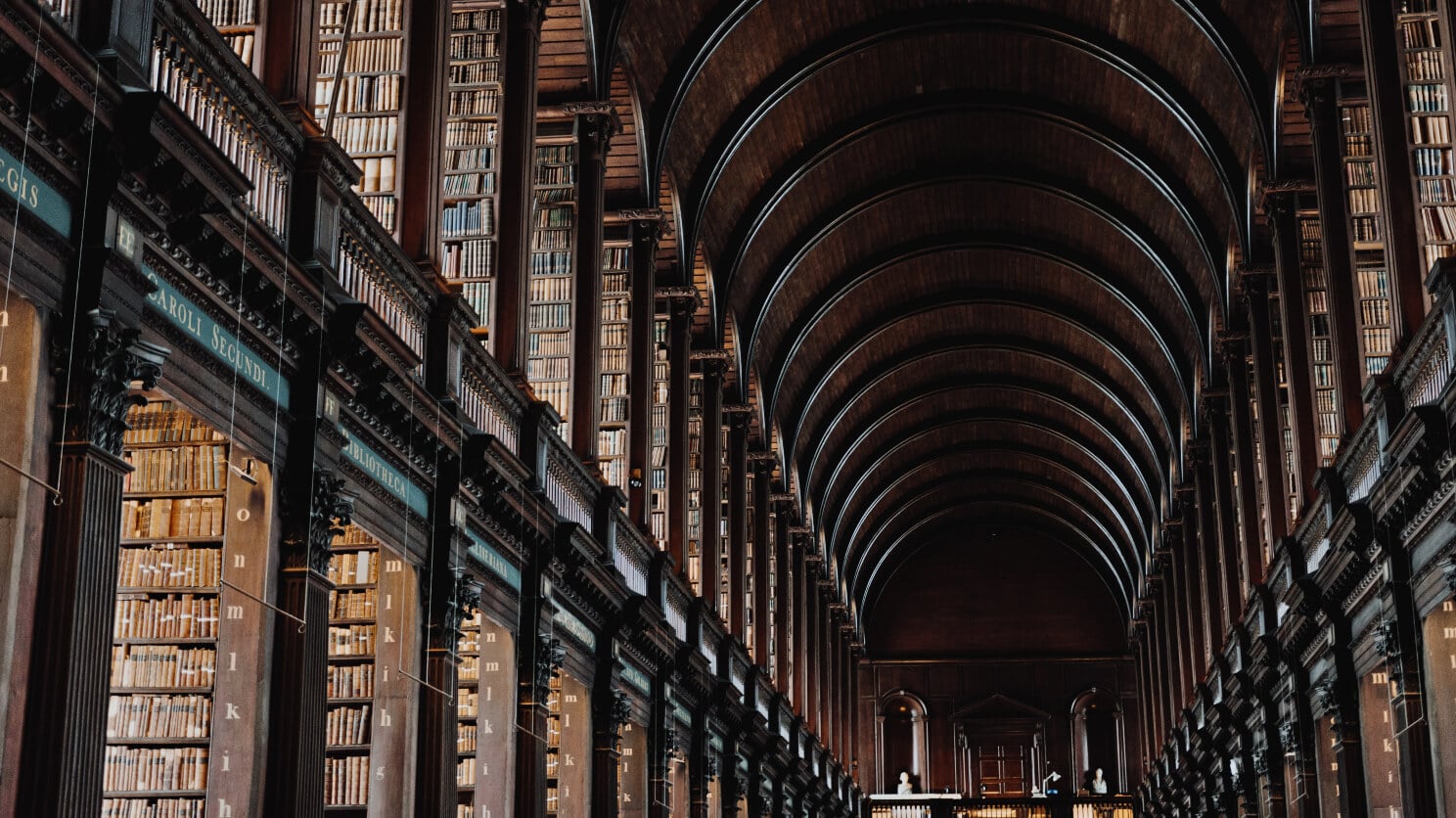
Le semplificazioni non postulano le gare d’appalto al massimo ribasso
17 Giugno 2021Articolo di Paolo Venturi, Direttore AICCON e Giulio Pasi, Joint Research Centre – European Commission pubblicato su Corriere Buone Notizie.


Si sente dire che viviamo in un’epoca di grandi trasformazioni. Eppure, osservando il dibattito pubblico italiano, l’accento cade sempre su quali siano i settori da difendere, promuovere, consolidare. Tutto comprensibile, ma con un però. Infatti, sembra esserci una falla nel modo in cui l’intero problema è affrontato. Si parte spesso dall’esistente, considerandolo come un dato immutabile, frutto di una visione deterministica dei processi storici che hanno portato a ciò che oggi abbiamo davanti ai nostri occhi. Non vogliamo polemizzare con difesa delle rendite o delle varie posizioni dominanti, e neppure discutiamo attività – lecite e legittime, diciamolo a scanso di equivoci – di lobbying. Ci interessa piuttosto quel riflesso incondizionato, chissà atavico, in virtù del quale ci si chiede come non perder ciò che si è guadagnato, come conservarlo e come farlo crescere. Se è vero che viviamo in una epoca di trasformazioni, questo approccio statico, per il quale ciò che conta è sostanzialmente un incremento del presente, dovrebbe essere sostituito da uno differente, diciamo dinamico, per il quale invece il criterio guida dell’azione è ancora una spinta ideale, che dia forma alla realtà, sia essa economica o sociale, o entrambe.
Si tratta più che altro di un effetto generato nel soggetto dalla conoscenza e dalla comprensione che questi riesce a trarre dai suoi vari tentativi di domare e plasmare la realtà. E tutto ciò è ancor più vero quando si parla di economia sociale. La tentazione, alla quale più volte si è ceduto in passato, di considerare l’economia sociale come un settore il cui valore è misurabile attraverso la conta delle organizzazioni e delle economie ad esse connesse, non porterà da alcuna parte. è emerso con chiarezza durante lo European Social Economy Summit, tenutosi a Mannheim il 26 e il 27 maggio, dove a gran voce è stato affermato da più parti che o l’economia sociale sarà motore di trasformazione e cambiamento sociale, o non sarà. Si fa strada infatti una visione dinamica, per la quale l’economia sociale si candida ad essere un dispositivo moderno per generare valore economico e sociale, rappresentando sotto tale etichetta una moltitudine di istituzioni capaci di trasformare le componenti “core” dello sviluppo e del welfare, oggi isolate e spesso concepite in ottica alternativa, rendendole più inclusive e sostenibili.
Occorre in altri termini allontanarsi da una possibile logica additiva (un’economia che si aggiunge alle altre, in settori a fallimento di mercato) e riparatoria (un dispositivo per rammendare le ferite del capitalismo estrattivo e le perverse inefficienze dello Stato sociale del secolo scorso), per aprirsi ad una visione costruita sul valore emergentista dell’economia sociale, un valore capace di cambiare e ridisegnare il campo delle scelte legate a competitività e coesione, nell’interazione con Stato e mercato. Deve emergere con forza l’idea che la sfida dell’equità e dell’inclusione han la loro premessa: una nuova generazione di istituzioni ed alleanze di scopo che generano e redistribuiscono valore secondo forme e schemi di cui sino ad oggi abbiamo visto solo alcune anticipazioni. Occorre uscire dagli eterni trade off fra equità e sviluppo. Questo non per ragioni di ideologia politica, bensì per una serietà con i dati che emergono dall’esperienza concreta che i diversi attori fanno nel loro agire economico.
L’economia sociale, non viene dopo Stato e mercato, e nemmeno sta a metà strada tra i due. Viene prima, molto prima. Solo una appannata consapevolezza storica potrebbe negarlo. L’economia sociale è infatti il prodotto dell’incontro di due fattori: la comunità, che come sottolineato da R. Rajan è stata troppe volte lasciata indietro, quasi uno sfondo che non cambia la trama della storia rappresentata sulla scena, e la solidarietà, che in linea con quanto affermano Genschel e Hemerijck si sostanzia nell’aspettativa di un mutualismo tra i membri di gruppi oggi diventati “anonimi” agli occhi di molta politica. Questa d’altra parte è la “ri-scoperta” su cui hanno iniziato a riflettere un gruppo di studiosi e pensatori che – dopo un primo incontro nel novembre scorso che ha attirato più di 800 partecipanti – trova oggi spazio in una inedita collaborazione tra la Commissione Europea e la Stanford Social Innovation Review.
Ciò che oggi ancora non viene percepito è che l’economia sociale – intesa nella sua accezione più ampia – sia l’unico protagonista capace di giocare su tutte le dimensioni che portano al cambiamento sociale. Una visione questa, particolarmente rilevante in una fase in cui il rilancio dell’economia è guidato da corposi investimenti nel digitale e nel green: due vettori imprescindibili per immaginare “il dopo” ma che non son in grado di garantirci che una società più connessa sia più umana, e che una economia più green sia anche più inclusiva e comunitaria. Se cambio deve essere, non basterà fare meglio o di più. L’economia sociale dovrà esser chiaramente riconosciuta (e farsi riconoscere) per ciò che effettivamente è: il volano della trasformazione che aspettiamo.
Fonte: Corriere Buona Notizie




